articolo
PALAZZO CITTERIO
Alza il sipario Caterina Bon su quasi mezzo secolo di misteri e di incomprensibile immobilismo che ha coinvolto il cuore artistico di Milano e che negli anni è stata chiamata 'Grande Brera', 'Brera 2', 'Brera in Brera' e 'Sistema Brera'.
Uscito quest'anno per i tipi di Skira, “Il caso Palazzo Citterio” è un lavoro ordinato di ricerca e di informazione che non solo spiega dei fatti che hanno dell'incredibile, non solo sintetizza 40 e passa faldoni d'archivio ma, soprattutto, traccia il quadro culturale, sociale e politico di Milano tra gli anni ‘70 e il 2010, che ha visto accavallarsi tre generazioni di ministri, di soprintendenti, di storici dell'arte, di critici, di personalità della cultura e di architetti, intenti, chi più chi meno, ad ampliare la Galleria Nazionale di Brera nel vicino Palazzo Citterio.
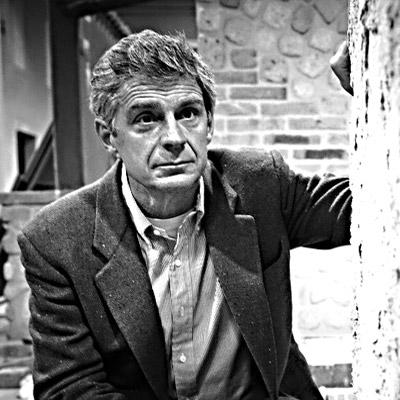
Alza il sipario Caterina Bon su quasi mezzo secolo di misteri e di incomprensibile immobilismo che ha coinvolto il cuore artistico di Milano e che negli anni è stata chiamata 'Grande Brera', 'Brera 2', 'Brera in Brera' e 'Sistema Brera'.
Uscito quest'anno per i tipi di Skira, “Il caso Palazzo Citterio” è un lavoro ordinato di ricerca e di informazione che non solo spiega dei fatti che hanno dell'incredibile, non solo sintetizza 40 e passa faldoni d'archivio ma, soprattutto, traccia il quadro culturale, sociale e politico di Milano tra gli anni ‘70 e il 2010, che ha visto accavallarsi tre generazioni di ministri, di soprintendenti, di storici dell'arte, di critici, di personalità della cultura e di architetti, intenti, chi più chi meno, ad ampliare la Galleria Nazionale di Brera nel vicino Palazzo Citterio.
Per far capire il contesto allargato nel quale sono iniziati i primi programmi di riuso e ampliamento di Palazzo Citterio, perché è là che nascono le idee e le promesse di donazioni di importantissime collezioni, Caterina Bon descrive, con ammirazione e non senza rimpianto, il clima culturale, la biografia di alcuni personaggi, le relazioni e i rapporti che caratterizzavano quella Milano della cultura e dell'arte. Colpisce qui, ed è pienamente da condividere, l'opinione dell'Autrice quando lascia trapelare che lei ha “... nostalgia di quel momento storico a Milano, di una società civile davvero illuminata che apriva al pubblico le proprie collezioni ben prima che fossero state vincolate, che pianificava con il soprintendente quali opere fossero da acquistare per Brera (e le acquistava e le donava), senza chiedere in cambio nulla se non il senso di partecipazione attiva al lavoro comune degli enti pubblici per il potenziamento culturale della propria città.” (p.22)
Affascina anche sia la descrizione della biografia di quella ristretta lista di persone “benemerite per la cultura e l'arte” che affianca le istituzioni, sia quella dei componenti gli 'Amici di Brera'; è qui ben dipinto il quadro dei rapporti, delle relazioni culturali, sociali e politiche che sono tutte inquadrate in un clima positivo di fiducia nel futuro. E’ interessante ri-conoscere in quel contesto socio culturale e tecnico figure importanti nel campo dell'architettura, del restauro e dell'industria, che si coagulano tutte intorno al Soprintendente Russoli e che ne diverranno stampella e supporto nonché coscienza critica.
La lunga storia degli incarichi per il progetto di “restauro”, degli appalti e della gestione amministrativa inizia dai giovani architetti Ortelli e Sianesi, preferiti agli archistar di quella volta - Caccia Dominioni, Zanuso e Gardella - i cui nomi erano parecchio sponsorizzati nella Milano di allora. Siamo in quegli anni molto particolari quando, nel ’75, grazie a Spadolini nasce il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, separandosi da quello della Pubblica Istruzione, fatto questo che avrà pesanti conseguenze per Brera, creando conflittualità e problemi di gestione. Al primo, ossia Ministero B.C. appartengono la Soprintendenza per i B.A e S., la Pinacoteca di Brera e la biblioteca Braidense, al secondo invece l'Accademia delle Belle Arti, l'Osservatorio e il Museo Astronomico e l'Orto Botanico.
Quasi contemporaneamente alla presentazione del progetto di 'restauro' (in realtà restauro proprio non era perché prevedeva delle pesantissime demolizioni quali lo scalone d'onore nell'ala tardo settecentesca, il sopralzo di due piani e altri corpi di fabbrica e altre) esplode la polemica che, partendo dalla qualità e dalla tipologia dell'intervento previsto si estende presto alla gestione, al programma di espansione di Brera coinvolgendo tutto e tutti.
Formulano pareri, opinioni e consigli i nomi illustri del restauro e dell'architettura di allora: Gnudi, Quaroni, Brandi, Argan; l'approvazione arriva comunque e con essa iniziano le demolizioni, tanto devastanti quanto gratuite. E’ un “restauro” questo, purtroppo in voga ora come allora, che trasferisce sull'opera in modo distruttivo e irreversibile i giudizi personali dell'architetto, un restauro che cancella la storia e crea nuove storie, un restauro che è in sintesi ennesima affermazione della propria personale creatività a discapito dell'architettura storica stratificata.
I lavori procedono per quasi due anni fin quando Italia Nostra (che per decenni è stato l'unico vero baluardo alla tutela dell'architettura e del paesaggio) denuncia il restauro di Palazzo Citterio "che è stato quasi completamente sventrato per un totale rinnovo .... La responsabilità di questi lavori ricade ai precedenti soprintendenti" (p.45). Così la polemica, prima cittadina poi nazionale, si allarga contestando anche la stessa scelta della destinazione d'uso che ha portato, sempre secondo Italia Nostra. "A uno snaturamento radicale dell'edificio".
Complice di ciò anche il cambio di Soprintendente (Bertelli sostituisce Russoli), che è ragione del secondo progetto Ortelli e Sianesi, approvato nel ’79, con conseguente ri-avvio fino al 1980 quando i lavori si ri-fermano causa, questa volta, il cambio del Soprintendente ai B.A.
Progressivamente il clima attorno al 'caso Citterio' peggiora. Fortemente critici sono i collezionisti Jesi e Junkers che minacciano, in modo diverso, di non rendere più disponibili le loro collezioni. Si genera così un effetto domino, come lo definisce Caterina Bon, per cui tutto viene rimesso in discussione: destinazioni d'uso, funzioni, scambi tra Citterio, l'Osservatorio Astronomico, l’Accademia, e viene definitivamente abbandonato il progetto Ortelli e Sianesi, mentre sullo sfondo è continuo il disaccordo tra soprintendenti.
Si arriva così al 1985 quando pare che i lavori debbano ‘ri-ri-ripartire’ alla grande ma poi, per ragioni diverse, che poi sono sempre le stesse, nell'86 si fermano nuovamente.
Nel 1986 cambia tutto (ma in realtà non cambierà niente), in seguito all'importante accordo tra Ministero per i B.C. e Istituto San Paolo di Torino che prevede, oltre ad una importante sponsorizzazione, anche un ruolo cardine per l'associazione Amici di Brera, la cui presidente è Rina Brion figura centrale negli anni successivi.
Si giunge così ad un nuovo incarico per il progetto, affidato direttamente dall'Associazione allo studio James Stirling, Michel Wilford&Associates, che nella sua seconda soluzione propone, oltre effetti scenografici importanti come la copertura del cortile con una cupola di vetro, anche la demolizione del corpo scale esistente (Ortelli, Sianesi), un nuovo blocco di collegamenti verticali e la costruzione di una scalinata nel porticato a est del cortile.
Nel 1989 il progetto viene approvato dal Ministero ma un contenzioso con i vicini (che è stato ignorato per decenni da una burocrazia sciatta e disattenta) è la ragione, insieme alla morte di Stirling, per un nuovo arresto dei lavori che si protrarrà fino al ’95, anno in cui si sarebbe potuto iniziare ma un nuovo (??) imprevisto, dovuto alla scoperta(?) inefficienza strutturale del corpo interrato ne causano l’ennesimo arresto.
Si arriva così al 2000, quando dal gioco del lotto arrivano circa 23 miliardi di lire in aggiunta agli 8 dell’ I.B.S.P. e pare che 'il caso' riparta, ma l'ennesimo cambio di dirigenti pubblici (ministri, sindaci, soprintendenti), unito soprattutto all'opinione contraria dell'allora sottosegretario Vittorio Sgarbi, comportano la definitiva morte del progetto Stirling e con esso della 'Grande Brera'. Alcuni modesti sussulti del moribondo palazzo Citterio sono ininfluenti circa la storia del lungo periodo.
Nasce ora la 'Brera in Brera', slogan apparentemente più fortunato, che comporta importanti scambi con altri edifici in città e si ha la sensazione che tutto riparta ma ... L'intrigo di responsabilità tra ministri, sindaci, soprintendenti direttori nazionali e regionali, che cambiano appena degli accordi si concretizzano, impediscono la conclusione della vicenda.
Ininfluente in questo è il succedersi degli architetti Licciardi, Barbjano di Belgioioso e Mario Bellini alla pinacoteca nel palazzo di Brera.
Il lavoro di ricerca di Caterina Bon finisce qui. E’ un approfondimento fondamentale per chi voglia capire la storia di un palazzo e, contemporaneamente, di mille palazzi, perché l'incapacità di gestione, unita a beghe politiche, potrebbero essere riferiti a qualsiasi monumento italiano da nord a sud. Le responsabilità di questa scandalosa vicenda, che haprivato Milano del suo cuore artistico per oltre 40 anni, naturalmente non è di nessuno perché in questa folla tutti i personaggi si nascondono uno dietro l’altro.
Personalmente ritengo che le responsabilità maggiori siano dovute ai vertici del Ministero dei B.C. (non dimenticando che gli organi periferici sono una sua emanazione), condotto prevalentemente da Ministri, da Spadolini in poi, senza capacità, senza personalità e senza cultura del settore (sospendendo il giudizio sull’attuale), interessato da sempre più a far roteare poltrone che alla realtà della cultura; non a caso tuttora è un Ministero ininfluente e marginale, quando invece dovrebbe essere uno dei principali del nostro Paese. L’incapacità di organizzare, indirizzare e gestire non è solo una profonda lacuna tecnica, che si riflette nell’immobilismo e di conseguenza nei costi, ma è anche anarchia negli organismi periferici che, non avendo una guida e un preciso indirizzo, si sentono indipendenti non avendo al contempo la capacità di esserlo.
Dispiace registrare nel prezioso volume due cose.
La prima è l'assenza di fotografie e di disegni di cui l'archivio sarà stato certo ricchissimo, e nei 40 faldoni ci saranno state documentazioni di tutti i tipi e epoche. Le immagini avrebbero consentito di capire meglio tante cose e, soprattutto, l'entità degli sventramenti e lo stato di abbandono avrebbero spiegato meglio, anche a chi quella realtà non conosce, il prima e il dopo di molte fasi. La seconda è che, se questo lavoro di informazione fosse uscito qualche mese prima del concorso internazionale, forse avrebbe messo i concorrenti in una situazione di maggiore conoscenza e con essa di maggiore sensibilità sia nei confronti della storia antica di Palazzo Citterio sia e soprattutto della sua storia recente.
A questo punto c’è un’altra storia di Palazzo Citterio, che inizia dopo la conclusione del recente concorso internazionale bandito dalla D.R. dei B.C. della Lombardia per fornire 'proposte tecniche funzionali e formali' al progetto preliminare steso dai soprintendenti Artioli e Terafina, e che tutti noi speriamo finalmente abbia un lieto fine.
E’ una storia che non è esente da critiche, soprattutto riguardo al progetto vincitore, che hanno cominciato a levarsi forti e chiare subito dopo la sua proclamazione. Tra queste è da riportare quella di Davide Borsa che ne ‘Il Giornale dell'Architettura' (n.117, primavera '14) chiosa “... L'indietro tutta espresso dalle mezze misure con cui si è affrontato il problema, non certo insormontabile, di ridare un assetto decoroso a istituzioni, musei e collezioni di Brera, ha ottenuto il risultato di potere finalmente affermare che l'operazione è riuscita ma il paziente potrebbe morire. Il che la dice lunga sulla lungimiranza delle scelte. .... Come giustificare le spericolate iperboli verbali che debbono sostanziare la certificazione dello status quo nel quale sprofondarono, oltre al miliardo per l'acquisizione anche i 23 miliardi del lotto, e gli 8 della Fondazione San Paolo per un museo che doveva essere pronto nel 2002?
Arriva il progetto di Amerigo Restucci, poi vincitore nonostante l'imbarazzante sciatteria formale: il pastrocchio, combinato con la complicità di Giovanni Carbonara, già vincitore spodestato a Monza, ci propone rendering orrendi con marziane atmosfere sottovuoto e luci al neon soprannaturali nei quali galleggiano pezzi di straordinaria edilizia corrente; l'ascensore trasparente da autorimessa chic e il giardino formale zen da municipio brianzolo affogati in grossolani cementi armati e vetrate antiproiettile. Nel nome di improbabili analogie siamo trasportati dal brutalismo al bruttismo decisamente inguardabile. Come ha potuto vincere? Ma certo, è colpa della legge sugli appalti al ribasso (nello specifico, quello maxi del 38% su 13.593.230 di euro di research consorzio stabile)... < l'architettura è troppo importante per lasciarla solo agli architetti - ha precisato Margherita Guccione del Maxi. - quindi diamola in pasto ai ribassisti, meglio se iscritti alla compagnia delle opere. >
Cesare Feiffer

